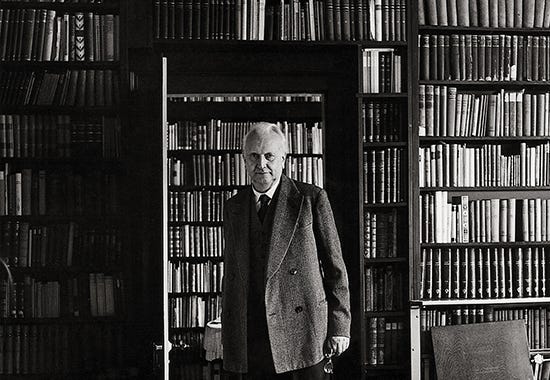Genio e follia: esiste davvero un rapporto tra creazione e crisi?
Da Virginia Woolf ad Antonia Pozzi, passando per Sylvia Plath e Cesare Pavese, Aristotele e le neuroscienze... una riflessione sulla mente e sul perché il buio, a volte, può insegnare la luce
Esiste davvero un legame tra genio e follia?
È una domanda che mi affascina da sempre. Non è un caso che nel mio libro Colazione al Parco con Virginia Woolf, come mi è stato ripetutamente fatto notare, una buona percentuale degli autori e autrici che ho inserito, hanno sofferto di disturbi psichici che spesso hanno portato a esiti tragici per le loro esistenze.
Credo che i libri ci trasformino, ci plasmino, ci aiutino a creare le nostre architetture interiori, fornendoci le parole per raccontare i nostri stati d’animo, capire le nostre emozioni, inquietudini e contraddizioni… e quindi mi sono chiesta: che cosa significa aver imparato tanto sulla vita da chi si è ammazzato?
La dico in termini brutali, perché non ne trovo altri. E a volte la crudezza serve per dare l’idea, più che tanti giri di parole.
Sono davvero convinta che chi ha vissuto sui crinali, e sente i crinali del buio dentro di sé, abbia accesso a forme di illuminazione e intuizione che gettano luce – a volte solo per un sprazzo- sull’esistenza. Un po’ come i quadri di Caravaggio- altro genio spericolato e oscuro: le luci dei suoi quadri non varrebbero nulla se non fossero contrastate dal buio.
Sylvia Plath, Virginia Woolf, Cesare Pavese… i miei scrittori del cuore, quelli che davvero mi hanno dato le parole che non sono stata in grado di trovare da sola per dare una forma alla vita, hanno combattuto con la fragilità della mente. Così come Antonia Pozzi, splendida ragazza che ha trasformato la storia della poesia italiana che tremava nel vasto inverno per la troppa vita che aveva nel sangue.
E così, per questa giornata dedicata alla Salute Mentale ho voluto fare un punto rispetto alle tante cose che ho letto e scoperto su questo tema… perché non solo se ne sono occupati filosofi e pensatori. Ma oggi anche le neuroscienze.
Un po’ di storia: “Perché tutti gli uomini straordinari sono malinconici?”
La domanda la pone Robert Burton nel 1621, nel suo libro L’anatomia della malinconia — testo monumentale che mescola scienza, filosofia, letteratura in puro stile barocco. Ma la citazione, in realtà, viene da più lontano: Aristotele, che nel Problema XXX.1 (che in realtà sono scritti dal suo allievo Teofrasto, ma non stiamo a guardare i peli nell’uovo…) osservava come molti uomini di genio — filosofi, poeti, politici, artisti — sembrassero affetti da uno stato cronico di melancholia.
Per i Greci, la malinconia non era solo un’umoralità negativa. Era uno dei quattro umori fondamentali (insieme a sangue, flemma e bile gialla) che regolavano l’equilibrio psicofisico. Chi aveva una predominanza di bile nera — mélaina chole — era più esposto a crisi depressive, ma anche capace di intuizioni profonde, visioni, creazioni straordinarie.
La malinconia come segno del genio (e della sconnessione)
Aristotele nota che molte personalità eminenti del suo tempo mostrano comportamenti eccentrici, solitari, intensi: caratteristiche che oggi potremmo leggere come tratti di un disturbo dell’umore o di una ipersensibilità neuropsichica. Ma già allora, l’idea prende piede: l’eccezionalità mentale è inseparabile da una certa “ferita interiore”.
Nel corso dei secoli, questa visione si rafforza. Seneca nei Dialoghi scrive che “non esiste ingegno senza un tocco di follia”. Nel Medioevo, la malinconia è associata tanto alla tristezza quanto alla contemplazione, alla lentezza del pensiero profondo. Nel Rinascimento diventa addirittura una condizione “nobile”, come nella celebre incisione di Albrecht Dürer, Melancholia I, dove una figura alata siede pensosa tra strumenti scientifici e oggetti magici, incapace di agire, ma attraversata da un’intelligenza luminosa.
Il positivismo e la “scienza” del genio deviato
Con l’Ottocento, però, il discorso cambia tono. Il romanticismo trasforma il “folle” in eroe tragico, e il positivismo cerca di dare al mito una forma “scientifica” — spesso forzata. Cesare Lombroso, padre della criminologia moderna, tenta di tracciare un filo diretto tra genio, devianza e malattia mentale. Secondo lui, gli artisti geniali mostrano caratteristiche fisiche e psichiche comuni ai criminali e ai pazienti psichiatrici. In Genio e follia (1864), Lombroso descrive una serie di “anomalie” comuni nei grandi scrittori, pittori e pensatori: squilibri affettivi, allucinazioni, vita sessuale irregolare, suicidi.
Lombroso ha oggi una fama controversa, e molte sue teorie sono state smentite. Ma la sua influenza culturale ha lasciato un segno profondo: l’idea che la creatività abbia qualcosa di patologico è rimasta nell’immaginario collettivo.
Genio e follia: cosa dicono le neuroscienze
Se per secoli il rapporto tra genialità e follia è stato materia di miti, aforismi e teorie filosofiche, negli ultimi decenni la questione è entrata anche nei laboratori scientifici. La domanda non è più solo retorica: la creatività ha una base neurologica? E condivide davvero qualcosa con la sofferenza psichica?
La risposta, a oggi, è: sì, ma con molte sfumature.
La creatività, nei termini delle neuroscienze cognitive, è spesso descritta come la capacità di generare idee nuove e utili, combinando in modo originale elementi distanti. A livello cerebrale, questo processo coinvolge tre reti principali:
la default mode network, legata alla riflessione interiore e all’immaginazione;
la salience network, che decide quali stimoli sono rilevanti;
la executive control network, responsabile del pensiero logico e del controllo inibitorio.
Negli individui creativi, queste reti risultano spesso più attive o più connesse tra loro, permettendo un flusso più libero tra idee, ma anche un maggiore disordine. Ed è qui che entra in gioco il legame con la vulnerabilità mentale.
Diversi studi hanno osservato una correlazione statisticamente significativa tra tratti creativi e disturbi dell’umore, in particolare con il disturbo bipolare. Le fasi ipomaniacali (cioè una forma attenuata della mania) possono effettivamente aumentare la produttività creativa, grazie a un surplus di energia, fiducia, associazioni rapide, pensiero fuori dagli schemi.
Lo psichiatra Kay Redfield Jamison, lei stessa affetta da bipolarismo e autrice del libro Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament, ha studiato le biografie di poeti, pittori, compositori… anche Virginia Woolf— trovando una ricorrenza di tratti affettivi instabili superiore alla media della popolazione.
Ma attenzione: la creatività non nasce dalla malattia, nasce dalla persona che, nonostante (o attraverso) la malattia, riesce a elaborare, contenere, trasformare.
Le scoperte genetiche: vulnerabilità condivise
Uno studio condotto dal Karolinska Institute in Svezia ha esaminato oltre un milione di persone, riscontrando che i familiari di pazienti psichiatrici gravi avevano una maggiore probabilità di lavorare in ambiti creativi (musica, scrittura, danza). Ciò suggerisce che tratti genetici legati a instabilità emotiva, pensiero non convenzionale e sensibilità aumentata, se non estremizzati, possano contribuire alla creatività.
Allo stesso tempo, uno studio dell’azienda genetica deCODE Genetics in Islanda ha trovato che alcune varianti genetiche associate al rischio di schizofrenia e bipolarismo sono più comuni tra scrittori e artisti.
Ma anche qui, la soglia è importante: nei casi clinicamente gravi, la creatività tende a ridursi, non a emergere. La patologia, quando paralizza o disorganizza completamente il pensiero, rende difficile ogni forma di produzione artistica.
Jaspers: il genio non è la follia
Nel primo Novecento, quando psichiatria e filosofia erano ancora profondamente legate, Karl Jaspers decide di mettere ordine in secoli di equivoci romantici. Filosofo, medico e pensatore esistenzialista, Jaspers pubblica nel 1922 Genio e follia: Strindberg e Van Gogh, un testo che ancora oggi rappresenta uno dei tentativi più lucidi di distinguere — senza separare del tutto — la malattia mentale dalla creazione artistica.
Il suo punto di partenza è semplice ma rivoluzionario: la follia non spiega il genio, ma può essere una delle condizioni attraverso cui il genio si manifesta.
Non è il delirio a generare l’opera, ma la capacità — umana e creativa — di trasformare il delirio in forma.
Jaspers elabora un metodo che chiama patografia: una sorta di biografia clinica, in cui analizza le opere d’arte alla luce della storia psichica dei loro autori. Studia quattro figure emblematiche: Strindberg, Swedenborg, Hölderlin e Van Gogh — tutti artisti segnati da esperienze psicotiche o depressive. Ma la sua conclusione spiazza i lettori dell’epoca, abituati all’idea romantica del “folle ispirato”.
Per Jaspers, il genio non nasce dalla malattia, ma dalla lotta contro di essa.
La psicosi può travolgere, ma può anche costringere la coscienza a un confronto radicale con l’esistenza — un confronto che, se riesce a farsi linguaggio, può generare arte. In altre parole: non è la follia a creare l’opera, ma la lucidità del malato nel resistere alla propria follia.
Per dirla in un alto modo: non è la malattia a “produrre” arte, ma il modo in cui l’artista riesce a trasformarla in espressione. In Van Gogh, per esempio, non è la psicosi a generare i quadri, ma la sua capacità di restare aggrappato al pennello anche durante i momenti più difficili. È la volontà di dare forma al disordine, non il disordine stesso.
Virginia Woolf
Ho la sensazione di impazzire. Non posso più andare avanti in questi tempi terribili. Non devo guarire questa volta. Ascolto delle voci e non posso concentrarmi sul mio lavoro. Ho combattuto contro ciò ma non posso combattere più.
L’intuizione di Jaspers — che il genio creativo non nasce dalla malattia, ma dal tentativo di trasformarla in forma — trova una conferma potente nella biografia di Virginia Woolf.
Woolf ha convissuto tutta la vita con una fragilità psichica che oggi chiameremmo disturbo bipolare, alternando fasi di lucidità e creatività intensa a momenti di oscuramento, crollo e silenzio. Ma contrariamente a quanto vorrebbe una certa narrazione romantica, nei momenti più gravi, Woolf non scriveva affatto. La psicosi interrompeva la scrittura, non la alimentava.
I suoi diari e le sue lettere mostrano chiaramente che i crolli arrivavano dopo la fine dei romanzi, non durante. È come se, portata a termine un’opera, tutta la tensione nervosa, il controllo formale, l’energia simbolica richiesta per “tenere insieme il mondo” si spegnessero di colpo. E a quel punto, la mente cedeva.
Ma è proprio questa dinamica — scrivere finché si può, finché la forma regge — che rende il gesto artistico di Woolf così straordinario. Nei romanzi come Mrs Dalloway, Le onde, Gita al faro, la sua prosa si fa quasi musicale, ritmica, piena di flussi percettivi. È la struttura stessa del linguaggio che lavora per contenere l’instabilità, non per esprimerla in modo incontrollato.
In Sulla malattia, uno dei suoi saggi più potenti e trascurati, Woolf scrive che il dolore mentale altera la percezione della realtà, costringendoci a vedere le cose “non come sono, ma come sembrano a una mente febbrile, fragile, ritirata”.
Antonia Pozzi: scrivere per restare umani
Tra le figure più affascinanti, struggenti e purtroppo ancora troppo poco note del Novecento italiano c’è una voce che, ancora oggi, continua a vibrare come un diapason tra poesia, introspezione e dolore: Antonia Pozzi.
Nata a Milano nel 1912, Antonia vive e scrive in un’epoca dominata da regole sociali rigide e da un clima culturale soffocante. La sua famiglia appartiene alla borghesia colta e conservatrice; suo padre, avvocato di fama e legato al regime fascista, le impone un controllo sottile ma costante. In questo contesto, ogni forma di ribellione — sentimentale, intellettuale o esistenziale — diventa una piccola frattura nel tessuto familiare.
Pozzi cresce con una sensibilità acutissima, una fame di assoluto e un’intelligenza non addomesticabile. Studia filosofia, si innamora del suo professore Antonio Maria Cervi, vive con intensità ogni cosa — e ogni cosa sembra ferirla profondamente. Soffre di una forma grave di depressione, in un tempo in cui non si poteva chiamarla così, né curarla davvero. Muore suicida nel 1938, a soli 26 anni, lasciando dietro di sé un diario di poesia vivissima e tagliente.
Leggere oggi le poesie di Antonia Pozzi significa entrare in uno spazio sospeso tra sopravvivenza e sparizione. I suoi versi non cercano di nascondere il dolore: lo attraversano. Non c’è compiacimento, non c’è isteria. C’è semmai una chiarezza spietata con cui la giovane poetessa guarda il mondo, e guarda dentro di sé.
In uno dei suoi versi più citati, scrive:
Per troppa vita che ho nel sangue
tremo nel vasto inverno…
È una dichiarazione brutale e bellissima. Qui il dolore non è un vuoto, ma un eccesso. Troppa vita, non troppo poca. Troppo sentire, troppo vedere, troppo essere. Il suo inverno interiore è vasto, non perché manchi qualcosa, ma perché c’è troppo di tutto. La fragilità, per Pozzi, non è una mancanza: è un’ipersaturazione.
Oggi, grazie agli strumenti dei Trauma Studies, possiamo leggere la sua opera non come una semplice testimonianza di sofferenza, ma come una scrittura che cerca di elaborare una ferita, trasformandola in forma. Come direbbe Cathy Caruth, il trauma è qualcosa che “ritorna” — e nella poesia di Pozzi ritorna sotto forma di immagini potenti: la neve, il vento, la montagna, il silenzio.
Pozzi non scrive per pubblicare… Scrive per non crollare. Il suo è un atto di resistenza intima e disperata. In componimenti come La porta che si chiude o Preghiera alla poesia, si sente la tensione tra il desiderio di comunicare e la sensazione di essere inascoltata, chiusa fuori dalla vita normale.
Ma anche nei testi più cupi, c’è sempre un gesto verso l’altro. Una volontà di contatto. Una richiesta di tregua. Come nella poesia Prati, dove scrive:
Ma noi siamo come l’erba dei prati
che sente sopra sé passare il vento
e tutta canta nel vento…
La natura, nei suoi versi, non è mai un semplice sfondo. È uno specchio. Pozzi non si sente “parte” della vita, ma la osserva da una distanza emozionale che è tipica di chi convive con un trauma profondo. Eppure canta. Eppure cerca.
Antonia Pozzi è stata spesso raccontata come una figura romantica, fragile, tragica. Ma questa narrazione la impoverisce. Come ha scritto la critica Cristina Giudice, Pozzi non è una poetessa della morte, ma del limite. È una donna che prova a dire l’indicibile. A trasformare l’invisibile in parola. A restare viva attraverso i versi.
Oggi, leggerla significa ripensare il rapporto tra arte e salute mentale non in termini di spettacolarizzazione del dolore, ma come spazio di verità. Non è il suo disagio a generare poesia, ma la sua capacità di non negarlo, di farlo parlare senza che lo distrugga del tutto.
Nel mondo attuale, dove la salute mentale è ancora spesso un tabù, la voce di Pozzi suona moderna, quasi profetica.
Antonia Pozzi è letta oggi da nuove generazioni che la trovano vicina. Nei social, nei podcast, nei corsi universitari, la sua figura torna a parlare. Non come simbolo del dramma, ma come esempio di come si possa scrivere — e vivere, anche se per poco — in modo lucido, poetico, vulnerabile. E quindi profondamente umano.
Forse non serve essere folli per essere creativi. Ma serve, a volte, passare attraverso il gelo. E sapere, come Pozzi, che anche nel vasto inverno, qualcosa può tremare — e resistere.
Cosa possiamo imparare?
Che è molto rischioso confondere la patologia con talento. Non è la psicosi a generare arte, ma può essere parte del percorso di un artista.
Come sono riusciti artisti, artiste, scrittrici e scrittori a resistere al buio? Cosa ci hanno trovato dentro?
Gli autori hanno saputo trovare le parole per il vuoto, una forma di appiglio nei confronti dell’abisso.
Nella vita di tutti i giorni di certo non si deve aspirare alla malattia mentale, ma le loro opere possono aiutarci a trovare la chiave per uscire dagli schemi, per trovare una connessione con quei lati che la società ci dice di non affrontare.
L’oscurità non è bella, ma fa parte della vita. E a volte è proprio dall’oscurità che emergono gli squarci di luce. Se sappiamo guardarci attraverso.
Bibliografia per chi vuole approfondire
Classici del pensiero
Aristotele (attribuito a Teofrasto), Problema XXX.1 – L’origine antica della domanda: perché gli uomini di genio sono malinconici?
Robert Burton, L’anatomia della malinconia (1621) – Un testo monumentale che intreccia scienza, filosofia e letteratura.
Seneca, Dialoghi morali – Dove scrive: “non esiste ingegno senza un tocco di follia.”
Karl Jaspers, Genio e follia: Strindberg e Van Gogh (1922) – Il tentativo più lucido di distinguere la malattia mentale dalla creazione artistica.
Saggi moderni e contemporanei
Kay Redfield Jamison, Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament (1993) – Una pietra miliare che unisce psichiatria e biografia artistica.
Nancy Andreasen, The Creating Brain: The Neuroscience of Genius (2005) – Spiegazione neuroscientifica del pensiero creativo e della vulnerabilità mentale.
Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello (1985) – Racconti clinici che mostrano come il cervello malato possa anche essere straordinario.
Antonin Artaud, Van Gogh il suicidato della società (1947) – Uno sguardo poetico e rabbioso sulla psicosi e la creatività.
Letteratura e testimonianze
Virginia Woolf, Diari – Per comprendere la relazione tra lucidità, crisi e scrittura. (consiglio anche la biografia di Nadia Fusini: Possiedo la mia anima)
Sylvia Plath, Diari – Poesia e disintegrazione mentale come due facce della stessa tensione.
Paolo Cognetti, L’Antonia. Poesie, lettere e fotografie di Antonia Pozzi (Einaudi) Un dialogo intimo tra due anime affini, che attraversa parole, immagini e silenzi per restituire la voce viva di Antonia Pozzi
Cesare Pavese, Il mestiere di vivere – Diario della mente inquieta di un intellettuale moderno
Per chi ama la connessione tra arte, buio e luce
Susan Sontag, Malattia come metafora – Sulla pericolosità di romanticizzare la sofferenza.
Cathy Caruth, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History – Il trauma come ritorno e come forma narrativa.
James Hillman, Il codice dell’anima – L’idea che la sofferenza possa essere anche vocazione e destino psichico.