Imparare a mirare bene
Bisogna imparare a essere felici di quello che abbiamo… Ma è vero che può bastare in questa società che corre veloce, che ci chiede tutto, che ci chiede troppo e a cui noi diamo tutto e troppo?
Colpire il bersaglio è solo una cosa che si può desiderare, ma non è una cosa che meriti di essere ricercata per se stessa.
Cicerone, De finibus bonorum et malorum, Libro III, paragrafo 6
Quanto è difficile uscire dall’idea del bersaglio e concentrarsi sul prendere bere la mira? Me lo domando spesso, e forse me lo domando da sempre.
Pensavo che con l’appropinquarsi della mezza età sarebbe stato più facile concentrarsi sul fare bene le cose e fregarsene dei risultati. Lo dicevano gli stoici (e anche Cicerone): il compito del tiratore non è raggiungere il bersaglio ma impegnarsi al meglio per farlo, indipendentemente dal risultato. Da lì dovrebbe derivare la nostra soddisfazione. È liberatorio: ho fatto il possibile, l’ho fatto per bene. Pazienza per come è andata. Però magari non riesco a pagare il mutuo, oppure non riesco a raggiungere quegli obiettivi (lavorativi, personali, ecc.) che mi ero prefissata.
Bisogna imparare a essere felici di quello che abbiamo… Ma è vero che può bastare in questa società che corre veloce, che ci chiede tutto, che ci chiede troppo e a cui noi diamo tutto e troppo?
E mi lancio in un volo pindarico che parte dalle chat delle “sorelle di chat” – non vi spiego il contesto, immagino lo conosciate – e il post di Jonathan Bazzi che ha fatto tanto infervorare la bolla che abito (il post lo trovate qui: lui ha pubblicato il suo estratto conto denunciando i bassissimi pagamenti nel settore culturale che ancora è considerato – come diceva Bianciardi negli anni Sessanta – un hobby, un’attività per privilegiati che si vogliono divertire).
Mi lancio in questo volo perché forse le due cose sono legate, da un filo sottile che si può chiamare: coerenza. Non entro nel merito del: andavano pubblicate o no delle chat private? Perché la risposta è probabilmente no, però si poteva fare perché diventate pubbliche.
Ma al di là di questo, una volta pubblicate, la riflessione è su quanto il comportamento privato debba corrispondere a ciò che si predica in pubblico. È come se io che predico di leggere libri, non leggessi nemmeno una riga. O se parlassi di cucina vegana ma mi nascondessi a mangiare il prosciutto crudo. Fare, essere. Sartre diceva che siamo quello che facciamo. Un imperativo che è diventato il mio mantra: non esistono le intenzioni, esiste quello che metti in atto nella tua esistenza per renderle realtà.
Io non amo i proclami, ed è il motivo per cui mi viene detto spesso: dovresti chiarire meglio la tua “mission” sui social, ripetere allo sfinimento in video di 60 secondi che i libri ti cambiano la vita, che si può essere donne, madri, ma anche lettrici e lavoratrici della cultura. Io non credo che servano proclami, credo che invece – perché noi essere umani funzioniamo così – nel mettere in campo un esempio, raccontare come sia possibile. Studiare e aderire talmente bene a quello in cui crediamo da diventarlo.
In un mix tra pubblico e privato, perché ormai i confini sono labili, soprattutto se si sceglie di rendere le questioni più pubbliche di quello che potrebbero essere, in questa società fluida, veloce, brandizzata, dove tutto (dal femminismo agli ideali) diventa marketing di se stessi, c’è solo una cosa che può salvare: l’etica.
E non lo dico da vecchia bacchettona, ma da una che si è ritrovata grazie alla filosofia a crearsi una strada in un mare di incertezze. E anche se non sempre è facile, anche se a volte le strade appaiono troppo tortuose per essere percorse, il fare bene le cose mi fa sentire meglio. Perlomeno soddisfatta di me stessa, nonostante tutto.
E su questa scia, venendo al tema “Jonathan Bazzi”, quello che mi sento di dire a chi lavora nella cultura, e si arrabbia molto per certe dinamiche, è ciò che ripeto a me stessa: comportati bene, fai le cose con preparazione e giudizio. Ma non farle gratis. Perché quando si accettano troppi compromessi per un po’ di visibilità, è difficile poi ricordarsi dove stavamo davvero mirando.
Intanto, se vi interessano i libri e come possono cambiarci la vita, ricordo il mio Colazione al parco con Virginia Woolf che trovate qui e in tutte le librerie.
Libri che ho letto in questi giorni
Consigliato per chi vuole:
Tornare, con dolcezza e un pizzico di nostalgia, ai vent’anni fatti di entusiasmi smisurati e paure paralizzanti.
Scoprire come i primi amori ci cambiano per sempre (anche quando finiscono).
Capire cosa resta, davvero, dei sogni dopo che la vita li ha messi alla prova.
Riflettere su quanto sia difficile – e necessario – imparare ad accettarsi nel tempo.
Tuffarsi in una storia d’amore e crescita che sa essere malinconica, sensuale, ma mai stucchevole.
Riconoscere che a volte la direzione giusta la trovi quando smetti di inseguirla.
Leggere un romanzo che parla di noi, di quello che eravamo e – forse – di quello che siamo diventati.
Se ti sono piaciuti Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, Un giorno di David Nicholls o i romanzi di Elizabeth Strout, amerai Cuore l’innamorato perché parla del tempo che passa, di quello che resta, di ciò che avevamo sperato e quello che si è realizzato – e di tutto ciò che c’è nel mezzo. In una parola: la vita. È un romanzo che ti fa pensare a quanto tempo abbiamo passato a cercare la direzione giusta, e a quante volte – senza nemmeno accorgercene – l’abbiamo trovata.
Il libro perfetto per il cuore dell’autunno. Anche se – lo ammetto – dopo le prime venti pagine ho provato un certo disagio. Non per noia, anzi. Ma perché forse non avevo nessuna voglia di tornare lì, in quei vent’anni pieni di incertezze, grandi afflati, speranze incandescenti, amori totalizzanti. E Lily King quei vent’anni li racconta così bene da farteli rivivere sulla pelle.
La protagonista viene soprannominata Jordan, come la Jordan Baker de Il grande Gatsby. Non è Daisy Buchanan, la donna idealizzata da sposare: Jordan è indipendente, coraggiosa, un po’ goffa e spesso tenera. È il tipo di ragazza – dice Yash, il ragazzo di cui si innamora – “da cui uno divorzia”.
E tu, leggendo, ti ricordi chi eri. Ti rivedi in quelle insicurezze, in quei sogni altissimi e nei vuoti sotto i piedi. Una malinconia dolce e pungente che Lily King sa trasformare in letteratura – soprattutto nella seconda e terza parte del romanzo, quando Jordan è cresciuta. Anche Yash e Sam, i due lati del triangolo, sono cambiati. I lavoretti da cameriera a Parigi, i sogni bohémien di New York lasciano spazio alla vita vera: matrimoni, figli, case in provincia, esistenze che sembrano andare avanti per forza d’inerzia.
A riportare tutto a galla è un evento doloroso – eviterò spoiler – che costringe i protagonisti a rivedersi, a fare i conti con ciò che sono stati e con ciò che sono diventati. Un po’ come succede in Mrs. Dalloway.
Cosa vedere al cinema (anzi… su Netflix)
“Così il cuore si spezzerà, eppure spezzato vivrà”.
Con un verso di Lord Byron si apre Frankenstein, il film che Guillermo del Toro sognava da una vita, da quando a nove anni lesse il capolavoro che ha cambiato la letteratura horror, scritto da una ragazza di diciannove durante un’estate all’ombra di un vulcano (sul rapporto tra Frankenstein e i vulcani indonesiani vi rimando a questo articolo di Chiara Valerio).
È un’opera gotica, poetica e profondamente contemporanea, capace di restituire il cuore dolente e ribelle del romanzo che ha inaugurato la letteratura dell’orrore moderna. Del Toro prende Frankenstein e lo riporta al suo centro: la creatura. Ma anche la creatrice.
Quando scrisse Frankenstein, Mary Shelley aveva già perso una madre (la filosofa Mary Wollstonecraft, morta di parto), una figlia neonata, e viveva con Percy Shelley, che aveva lasciato moglie e figli per scappare con lei. Era sola, giovane, incinta, e immersa in un’epoca – la Rivoluzione industriale – in cui la scienza sembrava voler dominare anche la vita.
Scrivere quel romanzo fu un atto di resistenza. E anche un atto di dolore. Frankenstein è un libro sulla creazione, sulla perdita, sulla colpa. Ma anche su una maternità impossibile, continuamente interrotta, annullata, rimpianta (Mary Shelley perderà 3 figli, oltre al marito tanto amato morto annegato a 29 anni di cui conserverà il cuore per 30 anni avvolto dalle pagine di un libro… così narra la leggenda). E soprattutto su cosa succede quando gli uomini si arrogano il diritto di fare ciò che la natura non gli ha permesso: creare la vita.
Del Toro prende questo dolore e lo trasforma in cinema. Lo scienziato Victor Frankenstein (Oscar Isaac) è un visionario ossessionato dalla morte, forse più artista che scienziato e il suo “mostro” (Jacob Elordi) non è il collage macabro che abbiamo visto al cinema mille volte, ma un giovane Prometeo che impara a muoversi, parlare, amare, e poi – inevitabilmente – a vendicarsi.
Ma la vera sorpresa è lo sguardo. Come nel romanzo, anche il film racconta la storia da due lati: quello del creatore e quello della creatura. E per una volta, non c’è un villain: ci sono solo due solitudini che cercano un senso. Il cuore del film sta tutto lì, nella possibilità di un incontro tra chi si crede Dio e chi non ha chiesto di nascere.
Non manca la riflessione sul potere, attualissima. Christoph Waltz interpreta un mercante di armi che vuole comprare l’eternità con la scienza, convinto che basti il denaro per diventare Dio. Un’aggiunta moderna, che rende il film ancora più politico. Ma il centro resta la compassione. Mia Goth, nei panni di Elizabeth, è l’unica a non giudicare, a tendere la mano.
Del Toro, come Mary Shelley, ci chiede: cosa significa essere umani? È il corpo? È la mente? È la capacità di amare, nonostante tutto? Nel mondo delle IA e dei corpi “perfetti”, Frankenstein resta una domanda aperta. Un’eco che rimbalza da un secolo all’altro.
Forse perché, come dice Del Toro, “i veri mostri non sono fuori, ma dentro di noi. I peggiori, oggi, portano la cravatta”. Ed è proprio in questo incastro perfetto tra romanzo e film che Frankenstein torna ad avere senso: non come mostro da temere, ma come specchio. Perché il vero orrore, ieri come oggi, non è nella creatura, ma nell’abbandono. Nell’indifferenza. Nella paura di accogliere ciò che è diverso.
Che sia un figlio, un amore, o un’idea.
Dove ci vediamo questa settimana?
Sabato 15 novembre, ore 12:30
Hedy Lamarr: una nuova protagonista per il Maestro dell’Avventura
Museo di Storia Naturale, Corso Venezia 55, Milano
In occasione di BookCity Milano, incontrerò Marco Buticchi per parlare del suo nuovo romanzo La più bella del mondo (Longanesi), un’avventura che attraversa secoli e continenti, tra passato e presente.
Un dialogo tra cinema, storia e letteratura, dai fasti dell’antico Egitto alla Golden Age di Hollywood, passando per la Seconda guerra mondiale. Protagonista: Hedy Lamarr, attrice iconica, inventrice geniale, collaboratrice dei servizi segreti e figura chiave del Novecento.
Letture a cura di Beatrice Buticchi.
Sabato 15 novembre, ore 16:30 – 18:00
Colazione al parco con Virginia Woolf. L’arte di innamorarsi dei libri (Vallardi)
Via Egidio de Magri, Milano
All’interno della XXVI edizione della rassegna Duemilalibri, presenterò il mio libro: un percorso tra romanzi indimenticabili, storie che ci accompagnano nel tempo, e letture che ci aiutano a riconoscerci. In dialogo con Camilla Ronzullo, in arte Zelda Was a Writer.
Domenica 16 novembre, ore 18:00
Colazione al parco con Virginia Woolf
In dialogo con Amanda Colombo
Biblioteca di Rozzano – Via Togliatti 105
Capienza: 60 posti
Un incontro dedicato ai libri che lasciano il segno. Con me, Amanda Colombo, libraia e autrice. Laureata in Filosofia, dal 1999 gestisce con il marito la storica libreria di famiglia a Legnano. Con Garzanti ha pubblicato il suo romanzo d’esordio Meno male che ci siete voi (2023), un inno all’amicizia, alla lettura e alle vite che si intrecciano tra gli scaffali.
Lunedì 17 novembre, ore 12:30
Inseparabili
Con Francesca Leoneschi, Iacopo Bruno
In dialogo con Marta Perego e Antonella Pescetto
Factory 32 – via Giacomo Watt 32 Milano
Una storia poetica e profonda, illustrata con straordinaria sensibilità visiva da Francesca Leoneschi e Iacopo Bruno. Inseparabili racconta l’incontro tra una creatura marina orfana e una bambina che ha perso il cuore, uniti da un viaggio negli abissi che li trasformerà per sempre.
Più che un albo illustrato, un’esperienza immersiva: le immagini sembrano suonare, profumare di salsedine, muoversi come alghe. Un’opera d’autore in cui testo e illustrazione si fondono in un design artigianale e narrativo che – come scrive Riccardo Falcinelli – riesce a far danzare lettere e disegni con “maestria acquatica”.
Una conversazione sul libro, sul lavoro creativo a quattro mani, sulla bellezza del dettaglio e sull’importanza del racconto visivo, anche per le emozioni più profonde.
Buona lettura e buona visione,
Marta




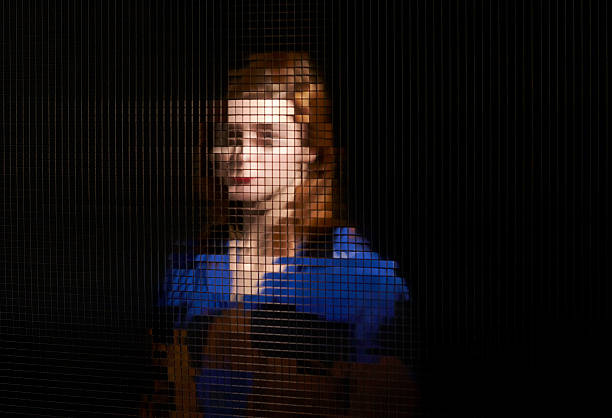



Mi ha colpito il punto in cui dici che non basta “fare bene le cose” se poi non si riesce a pagare il mutuo — perché è lì che si incastra tutta la contraddizione del nostro tempo: voler essere coerenti, etici, “buoni tiratori”, ma vivere in una società che misura tutto in risultati, visibilità e ritorno economico.
Eppure la tua riflessione mi ha ricordato che la vera forza sta proprio nel continuare a scegliere la coerenza anche quando non conviene, nel “fare bene” per dignità personale, non per compiacere un sistema.
Forse la felicità non è “accontentarsi di ciò che si ha”, ma riuscire a riconoscere il valore di ciò che si è, anche quando sembra che il mondo corra più veloce.
Grazie per averlo messo nero su bianco.